
…alla fine pensai che fare giustizia
non significa punire bensì risanare
non significa punire bensì risanare
Come può uno stato che cerca di uscire da una fase turbolenta della propria esistenza, mettersi alle spalle un passato ancora fresco nella memoria collettiva? I libri di storia, nell’appuntare un gran numero di situazioni di tale genere, ci raccontano anche come i periodi di transazione non siano affatto semplice da gestire, ma al contrario siano momenti di estrema delicatezza e con molti problemi da affrontare.
La modalità forse più diffusa per fare i conti con i trascorsi recenti è quella di fare fuori (spesso non solo in senso figurato) coloro che vengono considerati i principali responsabili della fase storica appena superata. Di esempi se ne possono citare a bizzeffe, dai gerarchi nazisti processati a Norimberga, al dittatore rumeno Ceaucescu, oppure il baffuto Saddam Hussein: i vincitori (o presunti tali) impongono la loro giustizia ai criminali che hanno condotto la nazione fino al baratro e che per questo non meritano nessuna pietà. Eliminando in questo modo l’origine del cancro, si crede di poter risanare le ferite aperte di paesi ancora atrofizzati dal dolore e dalla sofferenza. Le cronache dei nostri giorni sulla realtà irachena testimoniano però come questa strategia – lungi dall’essere risolutiva ─ possa addirittura gettare benzina sul fuoco, inasprendo rancori e conflitti che il poco tempo trascorso non può aver sedato.
Un secondo sistema per affrontare siffatte situazioni consiste nel mettere una pietra sopra a quello che è successo. Scurdàmoce 'o passato… recita una vecchia canzone napoletana, un passo che per certi versi sintetizza la filosofia dell’approccio che stiamo analizzando. Calare una coltre di silenzio quasi fingendo che nulla sia avvenuto, concedere l’impunità senza richiedere niente in cambio a coloro che si sono macchiati di gravi crimini, nascondere gli scheletri dentro l’armadio; è il prezzo che si paga per ottenere una pacificazione altrimenti impossibile da raggiungere. È questo un “modello” che mi dicono essere piuttosto diffuso in America Latina, con i vari Pinochet che si assicurano una pensione relativamente tranquilla dopo aver passato una vita a massacrare gente…E’ palese però che il negare l’evidenza dei fatti non è sicuramente il presupposto migliore per iniziare un percorso di giustizia e di riconciliazione tra vittime e i carnefici.
Ma per uscire da un passato oscuro, si possono intraprendere anche delle strade molto particolari. È il caso ad esempio del Sudafrica, che ha deciso di guardare in faccia il periodo più controverso e terribile della sua storia ─ quello del regime dell’apartheid ─ sperimentando una prospettiva veramente innovativa e straordinaria. La terza via scelta dal paese africano è descritta da colui che ne è stato probabilmente il protagonista principale, vale a dire il vescovo della Chiesa Anglicana Desmond Tutu, in un bellissimo libro dal titolo significativo: Non c’è futuro senza perdono. Un’ opera che descrive un cammino affascinante e sorprendente, peraltro risultato decisivo per traghettare il Sudafrica in una nuova fase storica, dopo i decenni bui del razzismo e della segregazione.
Siamo nel 1994; l’odioso regime dell’apartheid è finalmente venuto meno e Nelson Mandela è stato appena eletto presidente sudafricano. Si pone immediatamente la necessità di come affrontare – evitando pericolose degenerazioni in un contesto ancora assai delicato – l’ingombrante passato appena lasciato alle spalle. Non si può dimenticare quello che è successo, ma neanche intraprendere una campagna di giustizia sommaria sui crimini commessi. La fortuna del Sudafrica è però quella di avere dei dirigenti all’altezza della situazione, che capiscono che il nuovo corso deve essere improntato non sul rancore e sulla vendetta ma sulla riconciliazione e la verità. Nasce in questo modo un organismo nuovo, chiamato appunto Commissione per la Verità e la Riconciliazione, che avrà il compito di indagare sui crimini commessi durante il periodo dell’apartheid. La Commissione – guidata da Desmond Tutu – agisce tuttavia secondo un’ottica sui generis che non è quella di semplice punizione dei colpevoli. Il suo compito è invece quello di ristabilire la giustizia restitutiva, un concetto tipico della cultura tradizionale africana per cui fare giustizia significa innanzitutto […] correggere gli squilibri, ricucire le fratture dei rapporti, cercare di riabilitare tanto le vittime quanto i criminali, ai quali va data l’opportunità di reintegrarsi nella comunità che il loro crimine ha offeso. In questo senso, la Commissione intraprende un percorso volto al risanamento delle ferite di tutto il popolo sudafricano, coinvolto nella sua interezza dal morbo orribile dell’ apartheid. Un percorso che vuole dare sollievo tanto alle vittime, colpite da sofferenze indescrivibili, quanto ai carnefici, deviati da un regime perverso a compiere le azioni più deplorevoli.
In tale contesto, si decise che coloro che si erano macchiati di crimini politici potessero fare richiesta di amnistia. La richiesta poteva però avvenire solo a condizioni ben precise, la più importante delle quali era che l’imputato assicurasse una confessione piena e completamente veritiera dei delitti commessi. Questo era il prerequisito fondamentale perché la Commissione potesse accordare l’amnistia: l’immunità giudiziaria in cambio in cambio della verità totale. Come riconosce lo stesso Tutu, tale condizione ha richiesto un grande prezzo alle vittime. In molti casi, costoro hanno visto rilasciati i loro persecutori o quelli dei loro amici e parenti senza che ci fosse alcuna pena materiale da scontare…
Ma qui forse sta la straordinarietà dell’esperienza sudafricana, quello di aver mostrato che il senso di umanità sa andare oltre la materialità delle cose. La Truth and Reconciliation Commission ─ pur con tutti i suoi limiti e carenze ─ ha sostanzialmente assorto ai due compiti per cui era stata istituita, vale a dire quello di ripristinare la giustizia e quello di promuovere un cammino di riconciliazione ed unità. Che ciò sia avvenuto, può sembrare un miracolo…e forse lo è. E’ incredibile infatti come durante le udienze si sia realizzata una convergenza positiva di alcuni fattori psicologici e umanitari di notevole spessore...
Il primo di questi fattori era che, per la prima volta dopo anni, le vittime o i loro parenti avevano la possibilità di parlare pubblicamente dei soprusi subiti, di raccontare la loro storia e trovare finalmente un intero stato che li ascoltasse (tutti i processi erano trasmessi in diretta da radio e televisione). Le udienze pubbliche della Commissione erano l’occasione dove la gente poteva venire a piangere, ad aprire il suo cuore, a liberare l’angoscia che per tanto tempo era stata rinchiusa, ignorata, negata. Tutu evidenzia più volte il potere catartico del parlare e dello sfogo che in molti casi hanno permesso alle persone coinvolte di liberarsi di un fardello che ottenebrava il loro cuore.
Non bisogna dimenticare poi che la confessione dei colpevoli doveva sempre avvenire in presenza delle vittime, nonché delle telecamere che trasmettevano le udienze nell’intero paese. Nel corso del libro, Tutu ci ricorda più volte come sia difficile per una persona esprimere gli aspetti più reconditi della sua intimità. Spesso risulta difficoltoso raccontare le nostre piccole manchevolezze anche alle persone più care, figuriamoci narrare personalmente gli orrori perpetuati davanti alle famiglie delle vittime…Per i carnefici esisteva dunque una pena, molto più sottile di quella materiale, che era quella dell’umiliazione di essere additati alla riprovazione del pubblico. Molti di coloro che venivano messi alla sbarra erano sempre stati considerati fino a quel momento membri rispettabili della società e a volte la rivelazione del delitto giungeva per la prima volta anche per i loro cari, con conseguenze spesso negative per i legami familiari. Per un colpevole dunque, era forse più difficile sostenere una prova come questa piuttosto che finire in galera.
Ma il miracolo più grande si è sicuramente manifestato in una duplice disponibilità che ha investito molti dei protagonisti delle udienze: da una parte i carnefici che si sono dimostrati disposti a chiedere il perdono per i loro crimini, dall’altra le vittime che hanno saputo perdonare. Un esempio dice molto più di mille parole:
La Commissione tenne due udienze sulla strage di Bisho, una delle quali si svolge nella città stessa non lontano dalla scena del massacro. La sala in cui ci eravamo convocati era gremita fino al soffitto di persone che avevano partecipato alla marcia: molte di esse erano rimaste ferite e altre avevano perso un familiare o un amico. L’atmosfera vibrava di tensione […] Fu la volta di alcuni ex ufficiali della Cdf, tra cui un bianco. Quest’ultimo, il colonnello Horst Schobesberger, prese la parola a nome di tutti. Egli ammise che sì, erano stati loro a dare ordine ai soldati di sparare. A quel punto la tensione si poteva tagliare con il coltello. La folla non poteva essere più ostile. Fu allora che l’ufficiale, voltandosi verso il pubblico, lanciò un appello straordinario: “Vi dico che ci dispiace. Vi dico che il peso della strage di Bisho graverà su di noi per tutta la vita. Non ha senso desiderare che questo non sia mai accaduto, perché ormai è accaduto. Però io vi prego, io chiedo in particolare alle vittime, non di dimenticare, non posso chiedere questo, ma di perdonarci, di riaccogliere i soldati nella comunità, di accettarli pienamente, di cercare di comprendere anche le pressioni alle quali erano sottoposti in quel momento. Io posso fare solo questo. Mi dispiace, questo posso dire, mi dispiace”. La folla, che era stata sul punto di linciarli, rispose in un modo del tutto imprevisto: scoppiò in un applauso fragoroso! Incredibile! In un attimo il clima era cambiato […] Nessuno poteva prevedere che ci sarebbe stata quella svolta. Fu come se qualcuno avesse agitato una bacchetta magica capace di trasformare la rabbia e la tensione in quella manifestazione collettiva di accettazione e di perdono. Potevamo solamente inchinarci di fronte a questo ed essere profondamente grati per la capacità della cosiddetta “gente comune” di essere straordinariamente generosa e benigna.
Non aggiungo altro ai miei sproloqui personali su questo grande libro, se non il consiglio spassionato di leggerlo tutto di un fiato. Concludo però con un passo “antropologico”, relativo ad un aspetto peculiare della cultura africana che è risultato secondo Tutu decisivo per il buon esito dell’esperienza della Commissione:
P.S. Per Bossi e Borghezio. Se per caso passate per questo blog, dategli un’occhiata!
[…] La via da noi scelta è profondamente conseguente ad un tratto fondamentale della visione africana del mondo, quella che noi conosciamo con il nome di “ubuntu” nel gruppo linguistico nguni o di “botho” nelle lingue sotho. Che cosa ha spinto tanta gente a scegliere di perdonare invece di reclamare il castigo, ad essere magnanima e disposta alla clemenza invece di dar libero sfogo alla vendetta? Ubuntu è una parola difficile da rendere in lingua occidentale. È una parola che riguarda l’intima essenza dell’uomo. Quando vogliamo lodare gradatamente qualcuno, diciamo: “Yu, u nobuntu” cioè: “Lui ha ubuntu”. Ciò significa che la persona in questione è generosa, accogliente, benevola, sollecita, compassionevole; che condivide quello che ha. È come dire: “La mia umanità è inestricabilmente collegata, esiste di pari passo con la tua”. Facciamo parte della stesso fascio di vita. Noi diciamo: “Una persona è tale attraverso altre persone”. Non ci concepiamo nei termini “penso, dunque sono”, bensì: “Io sono umano perché appartengo, partecipo, condivido”. Una persona che ha ubuntu è aperta e disponibile verso gli altri, riconosce agli altri il loro valore, non si sente minacciato dal fatto che gli altri siano buoni e bravi, perché ha una giusta stima di sé che le deriva dalla coscienza di appartenere ad un insieme più vasto, e quindi si sente sminuita quando gli altri vengono sminuiti o umiliati, quando gli altri vengono torturati o oppressi, o trattati come se fossero inferiori a ciò che sono.
L’armonia, la benevolenza, la solidarietà sono beni preziosi. E per noi il bene più grande è l’armonia sociale. Tutto quello mina, che intacca questo bene a cui aspiriamo deve essere evitato come la peste. La rabbia, il risentimento, la sete di vendetta, la competizione aggressiva per il successo corrodono questo bene. Perdonare non significa soltanto essere altruisti, è il modo migliore di agire nel proprio interesse: tutto ciò che rende gli altri meno umani rende meno umani anche noi. Perdonare rende le persone più flessibili, più capaci di sopravvivere mantenendo la propria umanità malgrado tutti gli sforzi per disumanizzarle”.





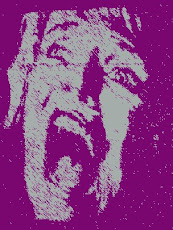







Nessun commento:
Posta un commento